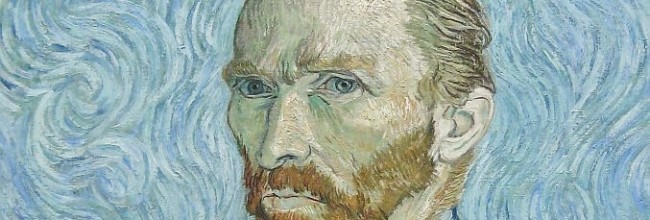Artemisia Gentileschi. Una vita vissuta tra pittura e passione
di Michele Lasala
18 maggio 2013 - Il lungo e intenso percorso di riscoperta e riqualificazione della pittura e della personalità di Artemisia Gentileschi comincia nel non troppo lontano 1916, anno in cui Roberto Longhi, uno dei più grandi storici dell’arte italiani del XX secolo, cui si deve anche il merito di aver ridato ossigeno alla figura di Caravaggio attraverso una grandiosa mostra dedicata al pittore lombardo al Palazzo Reale a Milano nel 1951, quando di Michelangelo Merisi si sapeva poco e niente, scrive un articolo (pubblicato sulla rivista L’arte) dal titolo abbastanza indicativo:Gentileschi padre e figlia. In questo breve scritto Longhi ci dice che Artemisia fu: «L’unica donna in Italia che abbia mai saputo che cosa sia pittura e colore, e impasto, e simili essenzialità […] nulla in lei della peinture de femme che è così evidente nel collegio delle sorelle Anguissola, in Lavinia Fontana, in Madonna Galizia Fede, eccetera».
UNA PITTURA VIRILE – In Artemisia dunque, secondo l’acuta osservazione di Longhi, non c’è nulla che rimandi alla pittura “femminile” di una Lavinia Fontana o di una Anguissola; la pittura della Gentileschi, al contrario, è una pittura virile, maschia, priva di leziosità ma carica di dramma e di pathos. Artemisia Gentileschi dipinge effettivamente come un uomo, dipinge come Caravaggio, dipinge come il padre Orazio, come Battistello Caracciolo, come l’olandese Dirik van Baburen. Dipinge avendo come punti di riferimento i grandi nomi del Seicento europeo, per diventare essa stessa un maestro altrettanto grande quanto lo stesso Caravaggio, il pittore che più di tutti ha influito sulla sua pittura. Ed è per questo che Roberto Longhi, dopo aver riconosciuto la grandezza della pittrice romana, eleva il nome di Artemisia alla stessa altezza di quello del padre Orazio, intitolando il suo scritto appunto Gentileschi padre e figlia. Ma è anche vero che, come dice la brava Tiziana Agnati, in una sua monografia dedicata alla pittrice, questo scritto di Roberto Longhi è il «primo serio tentativo di analizzare la produzione dell’artista nel più vasto contesto del caravaggismo e, soprattutto, di tentare una prima, accurata distinzione delle opere della figlia rispetto a quelle del padre». Dallo scritto del Longhi ad oggi numerosi sono stati gli studi condotti sulla figura di Artemisia. Accanto a questi non mancano biografie romanzate e film che raccontano il percorso artistico ed esistenziale dell’artista, ispirati dalla vita tormentosa e inquieta di una donna che ha combattuto tenacemente per affermare il suo essere e dimostrare il suo indiscutibile talento creativo, in un’epoca, il Seicento, in cui non era concesso a una donna di diventar pittrice.
ARTEMISIA, PITTRICE CARAVAGGESCA – Fino al 1610/15 Artemisia segue le orme del padre, dipingendo, sempre con una certa pacatezza e un certo equilibrio, non solo quadri di soggetto religioso, come la Susanna e i vecchioni (1610), o le diverse Madonne col Bambino, ma anche scene di genere, in cui compaiono molto spesso figure come suonatrici di liuto, scene queste ispirate ai quadri di analogo soggetto dei pittori olandesi del periodo. Ma il 1612 è certamente l’anno della svolta stilistica per la Gentileschi, perché questo è l’anno in cui la pittrice dipinge la prima versione di un quadro come Giuditta che decapita Oloferne, oggi conservato nel Museo di Capodimonte a Napoli, opera dichiaratamente ispirata ai quadri di Caravaggio. Da questo momento in poi la pittura di Artemisia si fa sempre più drammatica, sempre più cupa, sempre più inquieta. Pittura che segna il lungo periodo caravaggesco della Gentileschi. È questa la stagione in cui Artemisia attraverso la pittura ha modo di parlare di sé, del suo dramma e della sua inquietudine. Il 1612 è infatti anche l’anno in cui si celebra il processo contro il pittore Agostino Tassi per avere stuprato la pittrice. La Giuditta del Capodimonte ha tutta l’aria di essere un’istantanea fotografica di quello che poteva essere il desiderio di Artemisia rispetto al Tassi: tagliare la testa al proprio carnefice. E infatti non è un caso che il volto morente di Oloferne nella sua ultima notte sia proprio quello di Agostino Tassi, e quello di Giuditta ricordi i tratti somatici della stessa Artemisia.
L’ATTIMO FUGGENTE – Nel quadro napoletano la scena della decapitazione avviene in un ambiente indistinto. Una luce proveniente da sinistra illumina l’azione del delitto nel momento più drammatico, nel momento in cui Giuditta ha già operato il primo taglio sulla gola di Oloferne e il sangue del tiranno comincia a sgorgare macchiando le bianche lenzuola del suo letto. Oloferne si dimena ma viene subito bloccato da un’altra donna, la fantesca complice di Giuditta. Il tutto si compie in un attimo, in pochi secondi. Quello che la Gentileschi ha immortalato in questa scena è un momento cruciale, perché è il punto in cui Oloferne non è né vivo né completamente morto, un momento che ricorda la famosa foto di Robert Capa: Il miliziano morente, dove un soldato appena colpito da un proiettile sta per cadere al suolo, ed è tra la vita e la morte.
IL DRAMMA DI LUCREZIA – La potenza drammatica della pittura di Artemisia Gentileschi sta anche in questo: nel cogliere il momento di massimo pathos in una scena. E ciò lo vediamo anche in un altro quadro di stampo caravaggesco: la Lucrezia del 1621, opera conservata a Genova nel palazzo Cattaneo-Adorno. Qui Lucrezia è colta nel momento in cui sta per compiere il suicidio. Il corpo della donna emerge da uno sfondo scuro, buio, ed è illuminato da una forte luce proveniente, anche qui, da sinistra che vuole descrivere non già l’anatomia del corpo della donna, ma il dramma che sta compiendosi. Anche il volto della Lucrezia genovese ricorda il volto di Artemisia, ma la Gentileschi non si è suicidata. Ha preferito la vita nonostante la sua congenita inquietudine, ha preferito dipingere fino agli ultimi anni della sua esistenza, lasciando al mondo quadri capaci di raccontare nel loro insieme la cronaca della sua stessa vita. Una vita vissuta tra pittura e passione.
LA MOSTRA – Il BLU – Palazzo d’arte e cultura di Pisa ospita la mostra Artemisia. La musa Clio e gli anni napoletani. Dal 23 marzo al 30 giugno. La retrospettiva ripercorre le tappe del periodo napoletano di Artemisia Gentileschi.
Articolo pubblicato su www.quotidianolive.com il 13 maggio 2013